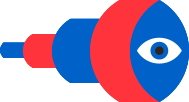Lo Chiamavano Jeeg Robot: un piccolo cult
Non fosse per Il ragazzo invisibile, uscito nel 2014, ora potremmo parlare di Lo chiamavano Jeeg Robot come del primo esempio compiuto di trapiantare il filone dei supereroi, tanto caro a Hollywood, all’interno dell’industria cinematografica italiana contemporanea.
Si tratta però di un mero vizio di forma se si conta che, all’epoca dell’uscita del film di Salvatores, Gabriele Mainetti era già al lavoro sul set con un soggetto preparato quattro anni prima e che solo le difficoltà connaturate all’uscita di un’opera prima ne hanno ritardato l’arrivo nelle sale.
Ma al termine della visione di Lo chiamavano Jeeg Robot il rimpianto più grande, al di là del vanto di essere cronologicamente “primi” in qualcosa, è l’impossibilità di pensarlo già in partenza sotto forma di serialità. Perché ad un certo punto, verso i tre quarti del film, la speranza è che la storia finisca un attimo prima dello scontro fra il superbuono e il supercattivo, lanciando così l’amo affinché tale evento si realizzi compiutamente nel capitolo due. Memori del reboot operato da Christopher Nolan sul brand Batman ricordiamo chiaramente l’emozione primitiva scaturita dalla vista, nel finale di Batman Begins, della carta di Joker che il commissario Gordon porge al futuro Cavaliere Oscuro come prova di una rapina a mano armata. Il cammino dell’eroe si ritiene compiuto solo in presenza del suo antagonista che, per il momento, è una figura fantasmatica ma già affascinante, proprio come lo sarebbe stato lo Zingaro interpretato da Luca Marinelli (attore di livello sempre crescente) se il film di Mainetti si fosse chiuso sulla scena del salvataggio della bambina da parte di Enzo, il futuro Jeeg Robot/Hiroshi Shiba.
Proprio perché il film, realizzato con coraggio e testardaggine, è un atto di amore così grande nei confronti del cinema e una dimostrazione così pura delle potenzialità di un gruppo di professionisti, dai già citati Mainetti, Marinelli, Claudio Santamaria fino alle luci di Michele D’Attanasio e alla scenografia di Massimiliano Sturiale, che non ci sentiamo disposti a sottostare ai tempi dell’industria italiana e vorremmo avere già una scusa (lo scontro fra l’eroe e il cattivo) per fare pressione sui produttori e per non attendere i due anni che ci sono voluti ad un altro piccolo cult, Smetto quando voglio, per annunciare la produzione dei capitoli 2 e 3. Certo anche lo sviluppo dei capitoli successivi de Il ragazzo invisibile è fermo da due anni, ma l’originale è stato un flop (8 milioni di budget a fronte dei 5 milioni incassati in Italia) e solo il nome di Salvatores ne garantisce l’interruzione della morte.
Il noir romano di Mainetti non ha niente né del teen movie triestino per come sfrutta il corpo della città, in equilibrio fra suburbe e monumenti, e soprattutto per come ragiona in profondità sulla creazione di un supereroe eccentrico scevro da sovrastrutture, complotti, destini mistici, idee messianiche, che potrebbe assomigliare ad Hancock, oppure al più recente Deadpool ma non è nessun di questi: è uno sfigato, un outsider, un delinquente, un represso che combatte contro un anti-eroe androgino, dalla sessualità variabile e che delinque più di lui. Ma la forza del film sta proprio in questo elemento di apparente caos, di esibita sgangheratezza, come l’avrebbe definita Umberto Eco, grazie alla quale nella stessa opera possono coesistere sequenze antitetiche, appartenenti a molteplici universi finzionali, tracce di mille altri film e generi che possiamo estrarre e riposizionare a nostro piacimento. La bellissima sequenza in cui lo Zingaro canta Un’emozione da poco al compleanno della malavitosa napoletana ha lo stesso valore della sequenza in cui Enzo forza la giovane Alessia ad avere un rapporto sessuale dentro un camerino, oppure allo scontro finale a suon di pugni devastanti. E se ognuno di questi momenti potrebbe bastare come sequenza cult è solo grazie alla loro unione che il soggetto si presenta completo e pronto a mostrare le sue qualità, quasi fosse uno di quei robottoni che, assieme a Jeeg Robot, hanno abitato le tv private dagli anni ’80 in poi.
Il rischio, come già predetto dai responsabili di Rai Cinema chiamati a valutare il primo soggetto di Mainetti, era che questa sgangheratezza, questo apparente caos potesse dar vita ad una stronzata colossale o ad un piccolo cult. Sarà il pubblico a mettere la parola finale ma possiamo tranquillamente già eliminare la prima opzione e propendere per l’affermazione totale della seconda.